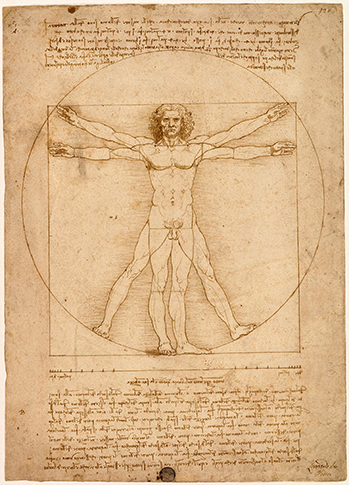Rimanete in me e io in voi
Giovanni 15,1-8 – Domenica, 2 maggio 2021, Quinta Domenica di Pasqua.
L’immagine della vite ricorre più volte nell’Antico Testamento e sembra che Gesù l’adoperi per trasmettere ai discepoli il senso e la forza (vis) del proprio insegnamento.
La pianta di vite era onnipresente nel bacino del Mediterraneo e lo è ancora oggi, ma ci si può chiedere in quale misura il richiamo alla somiglianza tra la vigna e il popolo di Dio venga compreso oggi nelle società urbanizzate.
La vite, quanto il gregge la scorsa domenica, ci avvicinano alla Scrittura e al contesto agricolo-pastorale nel quale accadono i fatti narrati; il testo è parte di un lungo discorso iniziato al capitolo 13 (dopo l’Ultima Cena) che termina al capitolo 17 con la preghiera sacerdotale e ha il suo culmine nel comando lasciato al versetto 17 del capitolo 15: “Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri”, la parola di Gesù forse più nota.
Esiste una certa confusione intorno a questo comando: l’ordine di amare, come se l’amore fosse una condizione assoluta da poter vivere a comando.
L’amore è spesso vissuto nel registro di una forte emozionalità, dentro una condizione nella quale, mentre non ne comprendiamo bene l’origine, allo stesso tempo comprendiamo con certezza che gioia è “presenza dell’amato”, tristezza è “mancanza dell’amato”, sia quando proprio non c’è (per esempio “è partito”), sia quando (peggio del peggio) ci ha lasciati o addirittura traditi. Detto in altri termini, l’amore è una questione molto seria … un vero … rompicapo.
Torniamo ai primi versetti di Giovanni 15, con l’immagine della vite e dei tralci, così spesso citata: “Io sono la vite, voi siete i tralci” Essere tralcio, rimanere nella vite vuol dire essere parte integrante di un processo che conduce … al grappolo d’uva: a portare frutto.
La fine dell’acino d’uva è quella di essere cibo, di essere bevanda, se pigiato e trasformato in mosto, o di marcire nel terreno e in quest’ultimo caso i semi contenuti in esso possono dare vita a nuove piante.
Questa parabola contiene anche avvertimenti che non dovrebbero essere equivocati:
“Ogni tralcio che è in me e che non porta frutto, lui (il vignaiolo) lo taglia” e “Se uno non rimane in me, è gettato via”. Anche qui dobbiamo fare prima di tutto riferimento al contesto storico (circa l’85 d.C.): i discepoli erano perseguitati ed esclusi dai luoghi di culto (la Sinagoga), quindi “si stavano radicalizzando” in risposta alla destabilizzazione causata dalle reazioni esterne alla loro piccola comunità. La loro finalità era probabilmente quella di fare chiarezza e di invitare i seguaci timorosi e titubanti a prendere una posizione decisa e determinata: chiamati a schierarsi in modo chiaro e risoluto.
Questo contesto di crisi restituisce tutto il senso della doppia polemica contenuta nella parabola della vite, quella che prende di mira i tralci sterili, ma anche l’opposizione tra Gesù, vera vite, e un Israele squalificato. Gesù non dice “Io sono la vite”, ma Giovanni gli fa dire “Io sono la vera vite”.
Giovanni è colui che scrive più chiaramente, senza ambiguità sulle caratteristiche di questa nuova chiesa che costruisce e istituisce un rapporto unico e autentico con il Cristo e con la buona novella rappresentata dalla sua predicazione.
Giovanni si rivolge a persone di cultura ebraica e il “comando” si connette con Esodo 20, potendo Gesù parlare con l’autorità di chi dice “Io sono”: l’identità, il vero nome di Dio, la vera vite come via, verità e vita; la vigna rappresenta in potenza l’umanità intera. Per questo i discepoli sono inviati e l’unico ulteriore e naturale nuovo comandamento è amarsi gli uni gli altri come il Cristo ha esemplificato. In altri termini una sola strada è possibile contro la protervia e la barbarie, e certamente non è la vendetta come ai tempi di Caino e Abele, ma il perdono in nome dell’amore e la giustizia in nome della comunità. La vigna, infatti – il Figlio e i suoi discepoli -, la vera vite coltivata dal Padre, proprio in base al nuovo comandamento non può che essere una comunità di “giusti”. L’impegno è forte, la scelta di appartenervi dev’essere decisa: “Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto”. (Sal 84,11-13). Così si pregava in Palestina ai tempi di Gesù, così pregano le comunità cristiane in tutto il mondo anche oggi. Perché la scelta di rimanere nella vigna dev’essere costantemente rinnovata e soprattutto consapevole. Dobbiamo sapere di che si tratta.
Talvolta l’amore diventa esigente, porta a decisioni che possono apparire perfino brutali, quali il taglio, la potatura, interventi necessari per far crescere più forte la pianta, per permettere che ogni tralcio possa essere nutrito da linfa abbondante.
Cosa succederebbe se la potatura non venisse praticata? Semplice: sarebbe colonizzata da succhioni e polloni (rami sterili e legnosi che si estendono dalla pianta senza portare frutto, depauperandola), i rami andrebbero dappertutto, si allungherebbero, si aggroviglierebbero, si renderebbero inestricabile, si esaurirebbero in pochi anni, e morirebbero prima i più deboli e poi i più forti. I più forti, rimasti ormai soli.
Non è questa la descrizione della vita di molti dei nostri contemporanei?
Potremmo dire che Gesù tra l’ultima cena e la passione “scolpisce” con la Sua Parola le verità fondamentali del proprio insegnamento, iscrivendosi nella tradizione religiosa del suo tempo e del suo ambiente, rifondando dall’interno la prima alleanza tra Dio e Israele. Per questo si parla di una seconda alleanza (nuova ed eterna), perché il discorso del Cristo è strutturalmente rinnovato e rinnovante.
L’amore non è vincolo (o comando) per titubanti, opportunisti, trasformisti e doppiogiochisti, ma condizione necessaria e sufficiente (conditio sine qua non) per rimanere, dimorare, salvaguardare, proteggere la vita e le vite: la vite, i tralci e i frutti.